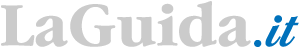Grinzane Cavour – A Jonathan Safran Foer è stato invece assegnato il Premio Speciale Lattes Grinzane, attribuito ogni anno a un’autrice o a un autore internazionale di fama riconosciuta a livello mondiale che nel corso del tempo abbia raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico. Safran Foer, 46 anni vive a New York. Ha esordito a venticinque anni con Ogni cosa è illuminata (2002), bestseller internazionale e vincitore del National Jewish Book Award e del Guardian First Book Award; ugualmente fortunato il secondo romanzo, Molto forte, incredibilmente vicino (2005). Da entrambi i romanzi sono stati tratti film di successo. Nel 2010 è uscito il suo saggio-reportage Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?, mentre l’ultim oromanzo, Eccomi, del 2016, è stato scelto come miglior libro dell’anno dalla giuria della Lettura Corriere della Sera. Nel 2019 è uscito il saggio Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Tutti i suoi libri sono pubblicati in Italia da Guanda.
Nella motivazione si legge: “Jonathan Safran Foer è stato un autore di caratura internazionale fin dal suo esordio, Ogni cosa è illuminata, pubblicato in Italia da Guanda nel 2002 e da cui è stato tratto l’omonimo film nel 2005, un libro che per trama e stile incanta ancora centinaia di lettori. Sin da quest’opera Safran Foer coniuga ricerca storica e fiction, racconto e ricerca stilistica, con risultati sorprendenti che attestano indiscutibilmente, anche agli occhi dei più scettici, la vitalità del romanzo e la sua capacità di ibridarsi con altre forme letterarie. Il suo passo di romanziere si adatta al meglio anche alla misura più breve del racconto, a cui riesce a dare particolare efficacia narrativa e una forte impronta etica. Sono molti i suoi interventi su testate internazionali rivolti a trattare i temi più urgenti del nostro tempo. Si tratta di articoli che richiedono l’acquisizione di una nuova e più forte consapevolezza sul clima, il cibo, la distribuzione della ricchezza. Emblematico in questo senso è il suo saggio Eating animals (2009) a cui, a distanza di dieci anni, segue We are the weather: saving the planet begins at breakfast. Jonathan Safran Foer, classe 1977, è tra gli autori più rappresentativi della sua generazione, che spazia con sicurezza e libertà tra le varie forme della narrazione e che, tanto per la sua etica quanto per la sua capacità di raccontare, è diventato un riferimento imprescindibile per i lettori di tutto il mondo”.
Ecco al lectio magistrali che ha tenuto ad Alba in occasione della consegna del premio. Il titolo è Cuori di macchina e la traduzione di Irene Abigail Piccinini
Da bambino pensavo: la gente una volta viveva in un mondo in bianco e nero; con la telepatia potevo controllare la musica alla radio; le sabbie mobili erano una minaccia onnipresente per cui dovevo sempre stare vigilissimo; le parole sulle mappe erano lettere giganti nel cielo; la luna mi seguiva…
Da adolescente ero convinto che il duro lavoro fosse universalmente ricompensato; che la legge servisse a proteggere tutti; che vivessimo in un’epoca illuminata e che presto l’ingiustizia sarebbe stata confinata nei libri di storia…
Da adulto ho pensato e qualche volta mi capita ancora di pensare, come più o meno il novanta percento della gente, di essere più onesto di quasi tutti gli altri e che quasi tutti i miei pensieri meritino di essere pensati – e in particolare quest’ultimo; di essere quasi indenne dall’influenza della pubblicità; e a dispetto di tutto ciò che ho ammesso fin qui, di sapere chi sono…
Fingere di sapere chi siamo è forse il torto maggiore che facciamo a noi stessi. Se lo sapessimo, sarebbe più facile affrontare le questioni che riguardano la tecnologia. Se sapessimo che cos’è meglio per noi, potremmo chiederci direttamente quali tecnologie contribuiscano a farci ottenere quello scopo e decidere di conseguenza. Sulla bontà di alcune tecnologie potremmo non essere in grado di esprimere un giudizio, ma sulla stragrande maggioranza potremmo applicare il nostro metro di valutazione e decidere in senso positivo o negativo.
Ma noi non sappiamo chi siamo. Più che l’assenza di risposta, il problema è che abbiamo dimenticato l’arte e la necessità di porci la domanda. O forse è persino peggio di così: siamo arrivati a credere che ammettere di non sapere chi siamo sia una debolezza. In un mondo in cui si dà più valore alla certezza che al contenuto di un’opinione, evitiamo deliberatamente, o cerchiamo di evitare, o siamo incoraggiati a evitare l’unica domanda ineluttabile. Evitando la domanda, accettiamo implicitamente le risposte predominanti nella nostra società tecnologica attuale.
È come se chiederci chi siamo o che cosa sia essenzialmente la tecnologia debba essere compito di qualcun altro. Domande del genere sono troppo imponenti, con ogni probabilità inutili e comunque sia è impossibile rispondere. Abbiamo tantissime cose di cui occuparci e non ne abbiamo il tempo. Non abbiamo neppure il tempo di fare i nostri acquisti in libreria o al supermercato, scrivere una lettera a mano, andare al cinema.
E invece il tempo per farlo ce l’abbiamo. La società tecnologica ci ha portato a credere che anche il nostro tempo non sia altro che una materia prima per creare nuove forme di materia. La società tecnologica ha trasformato un diritto di nascita – dare senso al passare del tempo – in un bene di cui solo chi è ricco di suo riesce a godere regolarmente, e spesso neppure. Abbiamo prodotto lo svago ma non il tempo libero, e lo svago serve solo a predisporci e ricarburarci per il lavoro. Invece di lavorare per procurarci da vivere, la nostra vita è messa al servizio del lavoro. Invece di avere comunità umane che coltivano le proprie aspirazioni con l’ausilio della tecnologia, le comunità sono parcellizzate in individui riorganizzati per essere al servizio della società tecnologica. Fa parte dell’ordine della società tecnologica, del meccanismo che ne permette l’invisibile funzionamento e la parvenza di normale evoluzione della nostra specie, come se fosse decretato dall’alto che la clava dell’uomo delle caverne ceda il passo al cellulare e poi via via fino all’ultimo capriccio reso bisogno indispensabile.
Ci preoccupiamo delle conquiste che la tecnologia rende possibili, ma è buffo come al tempo stesso la tecnologia ci spinga a favorire la sua stessa proliferazione invece del nostro benessere. Quasi tutte le innovazioni tecnologiche hanno in qualche misura migliorato la nostra vita, per quanto ne sappiamo. Oggi possiamo fare di più. Possiamo vedere di più e sentire di più. Possiamo lavorare più in fretta, essere più efficienti, sprecare meno. Possiamo essere dove vogliamo, vedere chi vogliamo. Possiamo arrivare nel caffè di una città straniera senza chiedere indicazioni. Possiamo sapere le malattie inscritte nel nostro codice genetico che si manifesteranno tra vent’anni. Possiamo sfogliare mille libri in una frazione di secondo. Possiamo ricordare il compleanno di tutti.
Abbiamo sempre l’impressione che la tecnologia faciliti e migliori le nostre vite, ma in qualche modo paga dividendi che non maturano mai come previsto. Tutti i piccoli passi che facciamo (o che siamo indotti a fare) nel complesso formano un gigantesco passo falso. O quantomeno un disagio crescente.
Ultimamente, quando ci svegliamo e andiamo alla scrivania con la nostra caffeina del mattino nella tazza, nell’inclinare il monitor e raddrizzare lo schienale delle nostre sedie regolabili ci scopriamo sempre più a disagio. In qualche modo, le dimensioni sempre crescenti dei monitor nascondono più di quanto rivelino e lo schermo amico dello smartphone che ci avverte cinguettando delle informazioni in arrivo non fa che interrompere i pensieri – come vogliamo che faccia.
Un quarto degli adulti sostiene di andare online «quasi costantemente». Il consumo mediatico dell’americano medio, compresi podcast e musica, supera le undici ore al giorno. È questo che vogliamo?
Forse?
Forse no?
«Cambierà tutto» è ciò di cui si vanta qualunque novità tecnologica di rilievo. Ma questo cambiamento ha una direzione, e come facciamo a sapere per certo che si tratti di una direzione positiva? È un progresso?
Oggi chi di noi ha la fortuna di avere una carriera professionale lavora più ore di quanto facessero i cacciatori-raccoglitori. A dispetto di tecnologie di comunicazione che sarebbero sembrate una magia alle generazioni del passato, isolamento e solitudine tali da richiedere cure cliniche sono frequenti. A dispetto di una produzione di ricchezza sufficiente ad affrancare tutti i cittadini del mondo dalla paura della fame e delle malattie non curate, continuiamo a confinare un’ampia classe di persone nella legittima preoccupazione di non riuscire a soddisfare i bisogni primari e una di gente davvero disperata in un’intensa sofferenza. È una paura che oggi ritroviamo anche nei college dove studiano i figli dei ceti più o meno privilegiati. Molti studenti universitari temono a tal punto di non trovare lavoro che optano per corsi vocati allo sbocco professionale a scapito della loro crescita intellettuale e spirituale, anche nei pochi anni in cui la società ammette in teoria che la cosa più importante sia la loro crescita umana. La tecnologia non doveva servire a liberarci dalla paura e dalla fatica per poterci dedicare a scopi più elevati?
Chi è disposto a credere che la tecnologia stia mantenendo le sue promesse? Eppure, la società tecnologica ha un abbrivio tale da indurci a offrirle la nostra fede – o quantomeno le nostre vite. In qualche modo, quasi nessuno mette seriamente in dubbio che una parte consistente dell’energia umana collettiva vada spesa a inseguire sviluppi tecnologici su qualunque scala, da ciò che mettiamo al polso ai satelliti in orbita intorno al globo, e in ogni settore, dall’istruzione alle forze armate alla sanità. Allo stesso tempo, è impressionante la facilità con cui vediamo – se abbiamo il cuore umano di guardare – l’immensità dei danni presenti e futuri che scaturiscono da questa dedizione, anche ad ammetterne i molti meriti reali.
I danni li vediamo, ma ci si dice che qualche sovvertimento è salutare e si indirizza il nostro sguardo a tutte le nuove, entusiasmanti tecnologie che, in effetti, sembrano migliorare di anno in anno. Se paragoniamo case, automobili, passeggini, tosaerba, sistemi di intrattenimento – praticamente qualsiasi cosa – di una generazione fa con quelli attualmente disponibili, un miglioramento medio in genere è evidente. E in qualche caso è aumentato il numero di persone che ha accesso a questi dispositivi: oggi è molto probabile che anche i più poveri abbiano un cellulare. E oltre a essere migliorati gli oggetti, sono migliorati anche i processi. Si può fare una ricerca su cent’anni di articoli di giornale in pochi secondi da casa invece di passare ore in biblioteca. L’organizzazione scientifica del lavoro e la proliferazione di «buone prassi» in ambiti diversi come la medicina, l’istruzione, le forze dell’ordine e le forze armate hanno portato a gestire il capitale umano in modo sempre più efficiente. I social media hanno facilitato i movimenti sociali.
Forse la tecnologia ci salverà, pensiamo, prima di dimenticarcene e seguire il prossimo link. Forse scienza e tecnologia produrranno la vita confortevole a lungo promessa – e non solo per me, ma per tutti. Poi arriva la notizia del prossimo orrore o della prossima assurdità e ci cascano le braccia, e pensiamo: Oh, santo cielo. O forse non proviamo nulla.
Gli esseri umani di questa generazione sono collettivamente più potenti di qualsiasi specie e generazione mai conosciuta sulla Terra. Nell’accrescere il potere umano sul resto del mondo naturale, il progresso è davvero innegabile e decisivo. Ma, nella dimensione individuale in cui viviamo effettivamente la nostra vita, la maggior parte degli esseri umani ha un potere maggiore?
Oscilliamo tra la fiducia in un mondo migliore e l’accettazione dello status quo. Purtroppo però il nostro ottimismo è sempre più rivolto alle banalità – un telefono, un’automobile o una serie televisiva migliori – mentre siamo scoraggiati su tutto ciò che conta: tutelare il mondo naturale dagli eccessi umani, soddisfare i bisogni umani primari, produrre cibo senza veleni e crudeltà, disporre di vero tempo libero in cui coltivare la vera libertà. Non c’è abbastanza tempo per queste speranze più elevate. I nostri dispositivi ci chiamano e, malgrado il disagio, siamo più o meno ubbidienti.
Non s’intende affatto negare l’immenso valore della tecnologia giusta al momento giusto. Se ti trovi in pericolo perché qualcuno ti attacca e ti allungano un’arma da usare come deterrente, dovresti prenderla e basta. Ma se poi il tuo benefattore va a dare la stessa arma al tuo nemico, ti renderai conto che non si trattava di un benefattore, bensì di un trafficante d’armi doppiogiochista. Che questo succeda con molte tecnologie è evidente: l’e-mail ci fa risparmiare tempo, ma non appena maturiamo quel dividendo di tempo, o forse anche prima, ci viene chiesto di più. Continuiamo a considerare chi promuove la tecnologia come un benefattore – e alcuni effettivamente lo sono, è ovvio, per esempio chi sviluppa i vaccini grazie ai quali l’impatto pieno delle pandemie ci viene risparmiato – ma in genere quella del profittatore è un’immagine più accurata. Oppure, con meno malizia, potremmo pensare ai guru della Silicon Valley come fossero un branco di bambini piccoli che entrano e gironzolano per primi in un capanno degli attrezzi, che cominciano a distribuire a chiunque degli altri bambini si spinga in prima fila… ecco qui un martello, qui una pala, qui un decespugliatore, qui una motosega: prendeteli e siate felici, che danno può venirne?
Molte tecnologie di comunicazione presumibilmente sono comparse come surrogati in chiave ridotta di un’attività impossibile. Poi però è successa una cosa strana: abbiamo iniziato a preferire i surrogati in chiave ridotta, o perlomeno a comportarci come se li preferissimo. È più facile telefonarsi che fare lo sforzo di incontrarsi di persona. Lasciare un messaggio in segreteria telefonica è più facile che parlarsi per telefono: puoi dire quello che ti serve senza reazione; è più facile trasmettere notizie difficili; puoi farti sentire senza rimanere invischiato. Così abbiamo iniziato a chiamare quando sapevamo che non ci sarebbe stato nessuno a rispondere. Inviare un’e- mail è ancora più facile, perché ci si può ulteriormente nascondere dietro l’assenza di inflessione vocale e, naturalmente, non c’è pericolo di incappare in qualcuno per sbaglio. Mandare un messaggino è ancora più facile, perché l’aspettativa di un discorso articolato si riduce ulteriormente e ci viene offerto un altro guscio in cui nasconderci. Ogni passo «avanti» ha reso più facile, anche se di poco, evitare il lavoro emotivo della presenza: scrivere LOL invece di ridere effettivamente di gusto, mandare una faccina che piange invece di piangere davvero, trasmettere informazioni invece che umanità.
La legge rabbinica tradizionale prescrive di muovere le labbra e di formare fisicamente ogni parola, quando si recitano per conto proprio le preghiere quotidiane. Non ci si può limitare a pensare le parole della preghiera o a intenderle e riprodurre una registrazione. A preoccupare i rabbini, tra le altre cose, è l’estrema probabilità che la nostra mente divaghi e finiamo per non avere pregato affatto. I rabbini sanno che non possono impedire alle nostre menti di divagare né imporre ai nostri cuori la giusta intenzione, ma insistono che la preghiera, per rimanere tale, deve incarnarsi nella nostra esistenza fisica. È da paranoico chiedermi se in un lontano futuro ci saranno bambini che invieranno faccine sorridenti e accigliate in base alla reazione che vorranno suscitare, del tutto ignari del fatto che un tempo sorridevamo e ci accigliavamo fisicamente per comunicare o dissimulare ciò che provavamo? Sicuramente non si arriverà fino a quel punto, ma quanto siamo disposti ad avventurarci in questa direzione?
Il problema di accettare – di preferire – surrogati in chiave ridotta è che, con il passare del tempo, anche noi diventiamo surrogati in chiave ridotta. È più facile dare l’amicizia a qualcuno che essere amico di qualcuno. È più facile mettere un like alle cose che amarle. La domanda è: è meglio? Può darsi che non tutte le cose difficili siano da evitare? Può darsi che alcune vadano cercate? Essere una persona che s’impegna profondamente con gli altri, che ama profondamente ed è profondamente amato è più difficile. Vivere con originalità, invece che in base a parametri fissi, riduzionisti, stabiliti dalle multinazionali, è più difficile? Comprare quello che ci vendono è facile. Più difficile è sottrarci dall’avallare chi siamo e invece esplorare il mondo, cercare il caso fortuito, cercare l’inaspettato e il nuovo.
Non è che la tecnologia – nelle forme in cui è entrata nella nostra vita quotidiana negli anni recenti – ci ha ridotto? E non è che ci sta riducendo sempre di più? Non è ovvio che sia così? Molte tecnologie ormai comuni suscitarono allarme, agli albori. Ci siamo adattati, giusto? Quindi forse non è necessario opporsi. Ma se fosse necessario, la resistenza da dove proverrebbe e che aspetto avrebbe?
La società tecnologica nasconde i propri difetti e falsa qualunque progresso presentandolo come fosse mosso da propri specifici motori. Immersi in un caldo torpore apatico, distratti da pseudo-eventi, prendiamo per buone le promesse della tecnologia e sventuratamente perseguiamo ulteriori soluzioni tecnologiche ai problemi tecnologici. Creiamo autostrade a corsie multiple per mettere fine agli ingorghi. Inventiamo una tecnologia a basso costo per fare videoconferenze, ma invece di vedere più spesso i nostri amici o colleghi lontani, ci ritroviamo più lontani dai nostri amici e colleghi. Siamo soli insieme, quantomeno a volte, quantomeno più di quanto ci aspettassimo o avessimo mai accettato. In mezzo a un rombo sordo e non localizzabile, alla connessione emotiva si sostituisce sempre di più una strana coazione di Sisifo a comunicare incessantemente. Stiamo creando la malattia e la chiamiamo cura.
Crediamo che le tecnologie soddisfino le nostre esigenze, ma oggi si può dire con altrettanta precisione che le tecnologie sfruttano le nostre esigenze, le nostre paure e le nostre speranze per ogni altro genere di finalità. Si stanno creando bisogni più in fretta degli appagamenti. Pensate a come usate l’email. È chiaro che ha agevolato la comunicazione. L’ha agevolata a tal punto che è diventato impossibile ricordare o spiegare come facessimo a fare qualcosa senza. Ma l’email ci rende meno impegnati? Ci fa sentire più vicini alle persone a cui teniamo? Ha agevolato la comunicazione, ma ci ha reso capaci di comunicare meglio?
E quale persona o istituzione ha ritenuto che questo fosse un modo migliore di vivere? Chi ha preso la decisione di cambiare la vita di tutti, in modo a quanto pare irrevocabile, perché era insoddisfatto della velocità del servizio postale?
A ogni generazione, è sempre meno possibile immaginare un futuro che assomigli al presente. I nostri nonni speravano che avremmo avuto vite migliori delle loro: forse il loro sogno più azzardato era che ci laureassimo. Se pensiamo ai nostri nipoti, ammettendo che il tasso di cambiamento tecnologico è parabolico, è impossibile immaginare come saranno le loro vite. Quali futuri escluderemo ritenendoli impossibili?
Nell’arco di tempo della nostra vita, le automobili si guideranno da sole, l’informatizzazione si sposterà dagli schermi ai nostri corpi e le stampanti 3D renderanno superflui i negozi. Un giorno, diciamo prima di quanto possiamo immaginare, i nostri problemi cardiaci saranno rilevati da nanomacchine molto prima che i sintomi ci portino da un medico. E altre nanomacchine ripareranno i nostri cuori senza farci sentire dolore, perdere tempo o spendere soldi. Ma ci sembrerà un miracolo solo se saremo ancora capaci di cogliere i miracoli, vale a dire, se il nostro cuore sarà umano.