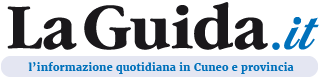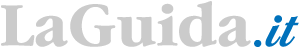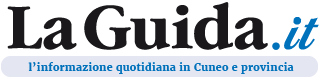Il 12 gennaio 1622 un gruppo di quindici cittadini illustri di Villafalletto decise di dare vita alla Confraternita della Misericordia, che sarebbe poi divenuta nota anche come Confraternita della Nera. Tra loro c’erano il “nobile messer” Amedeo Grimaldi, che sarebbe divenuto il primo rettore dell’istituzione, il sindaco e notaio Michele Antonio Falcone, il figlio dello speziale Francesco Pallotto, Giuseppe e Michele Antonio Grimaldi, Pietro e Gioannetto Giaccone, Stefano Pallo, Andrea Borgarino, Filiberto Falcone, Prospero Pesente, Gioffredo Colombero, Aurelio Roero, Antonio Viviano e Michele Antonio Ferrero, che negli anni successivi avrebbe raccolto il testimone di Falcone come sindaco del paese.
Decisi non soltanto a fare del bene e a dare nuova linfa alle istituzioni caritatevoli della comunità, ma anche ad affermare la propria posizione sociale nei confronti della parrocchia e della storica Confraternita del Gonfalone (o Confraternita della Bianca), i quindici notabili di Villafalletto acquistarono una casa in contrada Grande, nel cuore del paese: il venditore, Tommaso Messore, comprese fin da subito la portata epocale di quell’iniziativa e accettò di buon grado di cedere l’immobile, a condizione di poter essere annoverato egli stesso tra i padri fondatori della nuova Confraternita. La sua intuizione si rivelò fortunata: di lì a pochi decenni le fila del nuovo ente avrebbero superato il centinaio di confratelli, causando un sostanziale dimezzamento dei membri della Bianca.
Nel tentativo di sottrarsi all’aggregazione alle Diocesi di Fossano e di Torino, nel 1648 la nuova istituzione si affiliò all’Arciconfraternita di San Giovanni Battista dei Fiorentini di Roma e si dedicò alla cura degli ultimi: dal momento che in paese la Bianca già si prendeva cura di anziani, vedove e orfani, la Nera scelse di assistere gli appestati, le prostitute, i carcerati e i condannati a morte, imprimendo un forte salto di qualità alla beneficenza locale. Era severamente vietato, però, perseguire la gloria personale: le azioni di carità dovevano sempre essere compiute indossando un cappuccio nero sulla testa e i paramenti della Confraternita, in modo che non si potesse riconoscere l’identità del benefattore. Eventuali trasgressioni in un primo tempo venivano punite con una pena corporale, poi trasformata in una gravosa sanzione pecuniaria. Demolita la casa di Messore, nel 1675 prese forma una nuova chiesa, pensata fin da subito per incarnare un autentico gioiello del barocco locale e dedicata al culto di san Giovanni Battista Decollato. Di qui, in occasione della Settimana Santa, avrebbe preso il via la cerimonia del Mortorio Pasquale, momento di spicco tra le varie iniziative promosse dalla Confraternita della Misericordia. A differenza della pressoché totalità delle altre congregazioni cuneesi, sorte un po’ ovunque sulla spinta del fervore religioso della Controriforma per poi tramontare in età napoleonica e durante il primo Novecento, la Nera non ha mai cessato di esistere, e tuttora – insieme alla Bianca – rappresenta una delle istituzioni che definiscono l’identità sociale e culturale di Villafalletto.

La chiesa della Confraternita
A livello architettonico, la chiesa è formata da un’unica navata con due cappelle laterali. Fin dalla sua costruzione, l’edificio è stato pensato per ospitare la sacra rappresentazione del Mortorio Pasquale: la pregevole cornice che sormonta l’altare maggiore, in particolare, nasce per fungere anche da porta del Santo Sepolcro, mediante la temporanea rimozione della tela che raffigura il martirio di San Giovanni Battista e l’introduzione di una scala al posto del tabernacolo. Ad arricchire l’impianto contribuiscono le tre coppie di colonne di stucco nero, due tortili e una liscia, nonché i maestosi drappeggi che vengono tuttora installati e sostituiti dai confratelli a seconda delle varie ricorrenze religiose: i colori dominanti del complesso sono il rosso del sacrificio e il nero della penitenza, a cui si alterna la tonalità zucca tipica del barocco piemontese.
La cappella laterale di destra è dedicata alla Madonna dei Sette Dolori, ritratta da Giovanni Francesco Sacchetti in vesti blu e viola in compagnia di San Bartolomeo e San Giovanni della Croce: “La scelta cromatica – spiega lo storico locale Alessandro Tonietta – rinvia al blu della purezza divina e al viola della sofferenza. Il pittore non utilizza il nero del dolore, bensì il viola, che indica la sublimazione del lutto e la sua interiorizzazione, che conduce all’elevazione dell’anima”.
Completa la decorazione un pregevole palliotto stuccato di fine Seicento, realizzato insieme a quelli che ornano la Confraternita della Bianca e il santuario di Madonna degli Alteni. La cappella di sinistra è invece dedicata al beato Amedeo di Savoia, ritratto dal pittore di corte Bartolomeo Caravoglia insieme a Maria Vergine e a San Francesco da Padova.

“La presenza di un artista così prestigioso a Villafalletto – spiega Tonietta – è da ricollegarsi all’influenza della Confraternita della Nera, nonché ai legami politici che intercorrevano tra la famiglia Falletti e la corte sabauda: non a caso, all’interno dell’altare della cappella è anche custodita una reliquia del santo di casa Savoia”. Completano il patrimonio artistico della confraternita il ciclo pittorico dedicato alla vita e al martirio di San Giovanni Battista, che tradisce l’influenza di Rubens e di Salvator Rosa, e il pregevole coro ligneo situato dietro l’altare maggiore: qui la mano di un talentuoso ebanista ha scolpito accanto a ciascuno scranno dei confratelli due diversi “frutti” provenienti da tutto il mondo.
Tra i più curiosi, si possono individuare la fava del cacao e il mais, che si affiancano ad altri frutti più tradizionali e ricchi di simbologia come l’uva e il melograno. La torre campanaria, invece, risale alla fine del Seicento, e in origine aveva una struttura molto più massiccia: nel 1715 è stata sopraelevata su disegno del celebre architetto Francesco Gallo, che ha creato una parte terminale più slanciata e dai lineamenti simili a quelli di una pagoda orientale, scegliendo di utilizzare il disco stesso dell’orologio per delineare il peculiare profilo del campanile. Attualmente, il lato settentrionale è particolarmente deteriorato e la Confraternita della Misericordia ha da poco lanciato un appello a enti pubblici e privati del territorio alla ricerca di risorse economiche per effettuare un intervento di restauro: il costo preventivato si aggira intorno ai 135.000 euro.