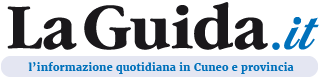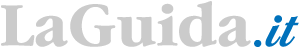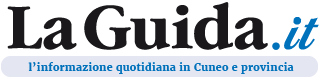Durante le festività pasquali si sono riaccesi i riflettori sulla collina di Saluzzo con l’attesa riapertura al pubblico di Villa Belvedere Radicati, al termine di un lungo intervento di restauro. Tra le novità più significative spicca l’apertura di un secondo ingresso, alternativo a quello posto di fronte alla cappella di San Grato: a poca distanza dalla chiesa di San Bernardino è stato ripristinato lo storico portale cinquecentesco, che può ora tornare ad accogliere i visitatori all’interno del parco alberato. Anche il giardino, ora arricchito da numerose essenze profumate e da un nuovo manto erboso, è stato interessato dall’operazione di rinnovamento, mentre nelle sale interne della villa sono stati installati video narrativi che raccontano la secolare storia dell’edificio e delle sue trasformazioni architettoniche. La storia della villa risale all’epoca del marchesato: a cavallo tra Trecento e Quattrocento, sul poggio collinare venne edificata una prima costruzione che aveva la duplice funzione di controllare la piana saluzzese e a di fungere da casa di caccia. A metà Quattrocento l’edificio subì una radicale trasformazione per volere di Ludovico II, che scelse di trasformarla nella residenza personale: la sua giovane consorte Margherita di Foix, infatti, non riusciva a sentirsi a casa tra le imponenti mura della Castiglia. Gli austeri spazi della precedente casa venatoria lasciarono così il posto allo sfarzo di una ricca villa rinascimentale, con una completa reinvenzione architettonica del fabbricato. Il declino politico, tuttavia, era in agguato: nel 1519, dopo la morte di Ludovico, il re di Francia mise gli occhi sullo stato saluzzese e scelse di esautorare Margherita, nominando in sua vece come marchese il figlio terzogenito Francesco. Il giovane venne nominato luogotenente generale degli eserciti francesi in Italia, e l’indipendenza della dinastia saluzzese conobbe un’irreversibile battuta d’arresto: tra alterne vicende, negli anni successivi anche la villa venne abbandonata e cadde in rovina.
Nel 1572 venne poi acquistata e radicalmente ricostruita da Carlo Birago, governatore di Saluzzo per conto del re di Francia, che le annesse anche l’ampio terreno circostante, noto da allora come “Vigna dei Biraghi”: nelle sale interne vennero così realizzati gli affreschi tuttora conservati nella villa, con paesaggi, grottesche e scene di battaglia. Nel 1604, il vecchio marchesato saluzzese venne ceduto dai francesi al duca di Savoia Carlo Emanuele I, che donò la residenza nobiliare, denominata “villa del Belvedere”, al conte saluzzese Gerolamo Vacca. Dopo la sua morte, sua moglie si risposò con il conte Francesco Bussone di Carmagnola, e la villa passò alla loro figlia Elena, che a sua volta andò in sposa al nobile rampollo Giovanni Battista Radicati di Marmorito e Passerano. Per tre secoli la dimora assunse il nuovo nome di “Villa Radicati”, finché nel 1977 l’ultima esponente della dinastia – la contessa Anna Maria Radicati di Marmorito – lasciò in eredità al Comune di Saluzzo la dimora: insieme con essa venne donato alla comunità anche un ampio assortimento di arredi, stampe, quadri e documenti d’archivio, oltre ai più di mille volumi della biblioteca privata. L’unico vincolo testamentario per l’amministrazione comunale consisteva nell’impegno a preservare l’identità artistica e paesaggistica della tenuta: ciò nonostante, la villa rimase in condizioni di abbandono fino ai primi anni Duemila, guadagnandosi così il soprannome popolare di “Villa dell’Eco”. Qui, infatti, come riporta Aldo Molinengo nel suo libro dedicato alla collina saluzzese, i bambini del paese erano soliti sfruttare l’acustica del lungo viale della villa, protetto da una cancellata, per un gioco ricorrente: urlare la domanda “Quante mele nel fagotto?”, per sentirsi rispondere dall’eco, in maniera nitida e distinta, la parola “otto”.
Nel 2002 il Comune ha poi stipulato un accordo con l’associazione Marcovaldo, che ne ha promosso il restauro e l’ha trasformata nella sede di numerosi eventi culturali e ricreativi. Dal 2016 la gestione è ritornata in capo all’amministrazione comunale, che l’ha poi affidata all’associazione Arte, Terra e Cielo. Immerso nel paesaggio collinare, ma situata a poca distanza dal centro storico, il complesso di Villa Belvedere Radicati è visibile anche in orario notturno grazie a un’illuminazione che ne esalta le linee architettoniche. Percorso il lungo viale di robinie situato oltre l’ingresso che si affaccia sulla cappella di San Grato si raggiunge il pozzo, con una caratteristica copertura multicolore in scandole di terracotta smaltate, che riprende lo stile del campanile della chiesa di San Bernardo nel centro storico di Saluzzo. Prima di addentrarsi alla scoperta delle sale della villa si possono ammirare i prati del parco, circondati da 2,87 ettari di terreno coltivate a vigneto e alberi da frutta. Sul retro del palazzo si può ammirare un antico cedro del Libano, che vanta un’età ormai secolare, mentre sul lato sud è presente un filare di ippocastani. La costruzione è caratterizzata da un’architettura imponente, con due ali porticate su entrambe le facciate; al suo interno numerose stanze sono ornate da affreschi rinascimentali recentemente restaurati, e sono stati ricostruiti sia la camera da letto che lo studio di famiglia, con biblioteca e scrivania da lavoro. Alcune stanze consentono di rivivere la storia dei più recenti proprietari della villa: è il caso, ad esempio, di Augusto Radicati (1879-1939), che fu capitano di vascello nella Marina militare italiana e primo comandante della nave Amerigo Vespucci. Sopra il tetto si affaccia una torretta a base quadrata che contiene il belvedere, da cui prende il nome l’intera villa: grazie a una spaziosa apertura su tutti i lati, si possono ammirare Saluzzo e la pianura fino a perdita d’occhio. Da questo punto nel 1762 lo studioso Giovanni Battista Beccaria effettuò una triangolazione con le città di Mondovì e Sanfrè per determinare la latitudine esatta di Torino, all’epoca denominata gradus taurinensis.