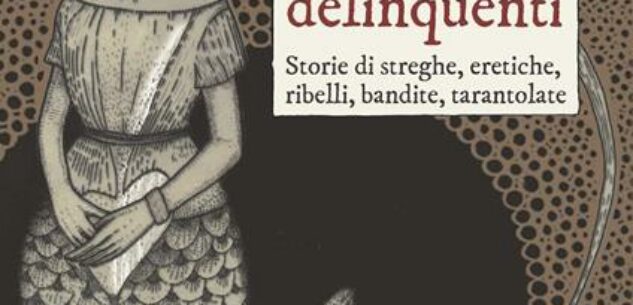Streghe e ribellione sono fenomeni inscindibili. Le prime rappresentano elementi sociali che si pongono ai margini di una comunità, silenziosamente la contestano. La cultura dominante dal canto suo non è disposta a mettersi in gioco considerando la possibilità stili di vita diversi. Di qui l’accusa di legami con forze oscure, maligne. In più sono persone, annota l’autrice, “appartenenti a un ‘sesso inferiore’ di cui però i maschi hanno paura (specie della loro lingua lunga); parte di classi subalterne illetterate, che non hanno potuto scrivere la propria versione dei fatti nell’unica forma legittimata dalla cultura dominante”.
Un Medioevo con processi e roghi è solo il momento più eclatante di un atteggiamento da secoli consolidatosi come baluardo difensivo della cultura e dello stile di vita. Perciò la riflessione sulla stregoneria e soprattutto sulle reazioni innescate nella struttura sociale, va considerata sotto molteplici aspetti. Metodologicamente si afferma la necessità di superare una dimensione strettamente fenomenologica. Non ci si può fermare agli eventi storici e i documenti che hanno prodotto. Senza sminuirne il valore, vanno letti come il risultato di un “inconscio collettivo che si impone ai contemporanei senza che questi riescano nemmeno a percepirlo (…). Bisogna impegnarsi a smaschera il non detto”.
Il saggio presenta un Medioevo fatto di tanti microcosmi rurali, autosufficienti, dispersi in territori coperti di foreste da cui traggono sostentamento. L’affermarsi delle città liquida affrettatamente queste comunità come “semplici” e chiuse, relegandole ai margini. Si delinea una scissione, presto scontro e prevaricazione tra la città degli uomini e quella della natura, di cui l’uomo è parte. È il presupposto per ribellioni. La religione viene chiamata in causa nella separazione tra credenze primordiali, magari anche in timido dialogo col cristianesimo, e una fede che diventa patrimonio dell’istituzione.
La foresta e la città come simboli ambientali di questa opposizione. Nella foresta si cela il mistero, fonte della paura trasmessa nei racconti popolari. La foresta è luogo di rifugio dei ribelli. La città è sede della giustizia, del potere costituito. Mediante i suoi schemi culturalmente più forti giudica la foresta e i suoi abitanti ora marginali in un tessuto sociale che punta sui viaggi, sulla moneta.
Le suggestioni metodologiche sono articolato punto di partenza per una ricerca ad ampio raggio. Mette a tema la vita quotidiana cercandovi gli spazi di libertà femminile e il ruolo sociale delle donne, aspetti frutto di una sedimentazione culturale i cui retaggi si manifestano in forme diverse. C’è poi il tema del corpo e della sessualità, la percezione individuale e comunitaria della fisicità con le relative preclusioni. Riflessioni a sostegno del capitolo finale intorno alla ribellione, consapevole o indotta dal pregiudizio. Le donne sono protagoniste e vittime. Diventano streghe dai rapporti con forze oscure.
L’analisi condotta supera il luogo comune che identifica nel potere religioso l’unica fonte della caccia alle streghe. Paradossalmente “non fu tanto la religione quanto il razionalismo militante che alla fine fece scomparire fate, streghe e altre creature silvestri”. E non fu storia solo letteraria, ma di dolori e morti, magari contaminata nella narrazione con la polemica strada dell’integralismo religioso.
Donne delinquenti
di Michela Zucca
Editrice Tabor
euro 16