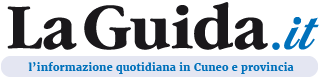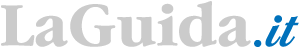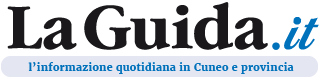Del progetto Museo diffuso del Cuneese fanno parte, oltre alcune delle chiese fossanesi, anche Palazzo Burgos e il Museo Federico Sacco.
Palazzo Burgos
L’elegante palazzo Burgos di Pomaretto sorge nel quartiere sud-est della città, che ospitava alcuni degli edifici di maggiore prestigio. Non a caso, l’odierna via Bava San Paolo era un tempo chiamata “via de’ nobili”. In quest’area avevano sede anche il convento e la chiesa dei Francescani Conventuali, poi soppressi in epoca napoleonica. Si trattava del più esteso isolato del concentrico, poi frazionato e riadattato con la trasformazione in residenza signorile. Esternamente l’edificio appare possente e maestoso; sembra non voler esprimere il rango superiore a cui appartiene, in nome di una riservatezza tipicamente piemontese. Le aperture e gli elementi raffinati vengono preservati per gli spazi interni destinati all’accoglienza, allo svago, al diletto. Palazzo Burgos, in particolare, possedeva fino a pochi anni fa un grandioso giardino di cui sopravvive oggi il pozzo. Gli studiosi lo hanno definito “l’area verde più preziosa della città”, in seguito trasformata con le demolizioni della chiesa francescana.
Internamente, la distribuzione degli spazi si articola secondo gli elementi tipici dell’architettura civile settecentesca: atrio, portico, scalone, galleria, salone. La decorazione pittorica interna si sviluppa intorno alle vicende del mito di Orfeo; i soggetti affrescati sono disposti negli ambienti del palazzo secondo la successione della strada percorsa dal protagonista. L’atrio di ingresso – poco illuminato e affrescato come una caverna – è paragonabile all’oscurità del regno delle ombre. Nell’androne ci accolgono finte architetture con elementi all’antica come obelischi, sfingi e figure mitologiche: Leda e il cigno, Zeus e Io, i Dioscuri. Delicati squarci aprono idealmente gli spazi con aperture circolari che mostrano il cielo percorso da voli di farfalle, felci, ciuffi d’erba. L’alternanza tra scorci architettonici e vedute naturali continua anche lungo lo scalone: questa commistione tra reale e dipinto doveva sembrare ancora più evidente se consideriamo la presenza del lussureggiante giardino all’interno del palazzo, oggi perduto. Sulla volta dello scalone ci accompagnano allegorie del lavoro e dell’amore e ci conducono all’atrio del primo piano dove ci accolgono i busti dipinti di Omero e Alfieri.
L’ambiente più spettacolare è senz’altro il salone d’onore interamente dipinto con temi allegorici. Sulla volta è affrescata la genealogia degli dèi.
Museo Federico Sacco
Lungo Via Roma, nei locali della tesoreria della Cassa di Risparmio ha sede il Museo Federico Sacco. Inaugurato nel 2021 il museo ha come obiettivo di stimolare il turismo geologico e valorizzare alcuni dei siti geomorfologici e paesaggistici rappresentativi della storia delle Alpi. Del progetto fanno parte una app per dispositivi mobili, un sito web specifico con percorsi e giochi che esplorano i 22 geositi coinvolti e uno spettacolare video che accompagna nella visita al museo e ci fa viaggiare nel tempo insieme ai due personaggi protagonisti del progetto: Martel e Sacco.
La prima sala è interamente dedicata alla figura di Federico Sacco, tra gli autori della monumentale opera in 30 volumi “I Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria”, che ancora oggi è un punto di riferimento per gli studi. Qui sono esposti alcuni dei volumi scientifici scritti da Federico Sacco e molti fossili correlati alle sue ricerche, fra cui alcuni della sua collezione e altri provenienti dall’Università di Torino.
La sala successiva accoglie il visitatore con una spettacolare spirale del tempo, che spiega la successione delle ere geologiche. Altre installazioni e pannelli mostrano la formazione delle rocce sedimentarie e magmatiche con ricostruzioni fatte da ologrammi, l’ambiente delle grotte cuneesi, la complessa storia della cattura del Tanaro, mentre un grande schermo proietta video a tematica geologica. Una sezione particolare è dedicata alla Foresta Fossile di Fossano, scoperta nell’agosto 2016 dal fossanese Pier Luigi Beraudo nelle marne del fiume Stura, a valle del ponte di San Lazzaro. Si tratta di un piccolo giacimento di legno fossile con resti di conifere che può fornire preziose informazioni sulle condizioni ambientali di circa 4 milioni di anni fa. Nella piccola saletta attigua, appositamente oscurata, una vetrina mostra i minerali fluorescenti: è possibile accendere a scelta le luci nel visibile o nell’UV per osservare come cambiano le emissioni luminose. Presente anche un’aula didattica.