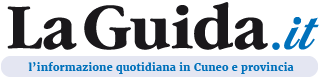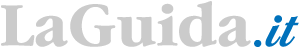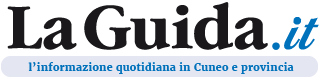Il complesso di San Costanzo al Monte, capolavoro di arte romanico-gotica, è considerato una fra le più interessanti testimonianze di architettura sacra basso medioevale. Probabilmente nato nei primi anni del IV secolo d.C. sul luogo del martirio di Costanzo ed ampliato in epoca longobarda, il complesso fu successivamente interessato dall’ondata distruttrice saracena che caratterizzò molti centri monastici del basso Piemonte. Il recupero e la ricostruzione dell’antica chiesa romanica sono tradizionalmente ricondotti alla contessa Adelaide la quale, nel secolo XI, sostenne quella rinascita e quell’ampliamento che caratterizzarono anche i secoli successivi, ricchi di fervore artistico ed abilità costruttive.
Nei secoli XVII e XVIII la chiesa alternò poi momenti di decadenza ad altri di fioritura, per essere infine ceduta, in epoca napoleonica, ad un geometra dronerese come paga di alcuni lavori da lui effettuati per il governo francese.
La chiesa si sviluppa su due livelli. Nel piano inferiore si trova il luogo della cripta romanica in cui si vuole che fossero conservate le reliquie del santo martire. La sua pianta ricalca esattamente l’impianto basilicale della chiesa superiore, che occupa una posizione di particolare interesse sul panorama architettonico nazionale. Le tre absidi della cripta sono illuminate da finestrelle arcate a doppia strombatura. Un testo della fine del XVI secolo testimonia la presenza delle reliquie di San Costanzo all’interno della cripta, dove la tomba del martire sarebbe stata violata da un negromante. La lapide è oggi conservata all’interno della Chiesa Parrocchiale di Villar San Costanzo. Da ovest, un nartece dà accesso alla cripta. Al di sopra dell’arco di ingresso della navata centrale corre una cornice composta da pezzi di reimpiego della chiesa precedente. Questi raffigurano palmette, intrecci e creature mitologiche. Di grande interesse sono anche i due pilastri che sostengono l’arcone d’ingresso scolpiti col motivo degli intrecci a matassa e di fattura anteriore al XII secolo, sormontati da due capitelli a mensola, entrambi raffiguranti una colomba.
La presenza di alcuni locali attigui alla chiesa, inoltre, testimonia l’esistenza di una dimensione più quotidiana e materiale che, a partire da un dato momento, incominciò a gravitare intorno a San Costanzo. In particolare, un documento del 1771 descrive i locali addossati al lato sud specificandone alcune funzioni come quella di casa “focolare”, di stalla o di fienile e identificando l’edificio ubicato verso valle con l’appellativo di Casa Fracida. Il lato nord-orientale della Chiesa presenta ulteriori locali attigui, tra i quali si nota la presenza di un forno con soprastante locale da destinarsi all’essiccazione. Oggi restaurato, nella seconda metà del XVIII secolo il forno si presentava in pessimo stato. Lo stesso documento testimonia la presenza di una vecchia torre campanaria, dove è ora presente l’attuale campanile a vela, alla base del quale sono state ritrovate delle tegole di modulo romano che recano una serie di marchi impressi a crudo. Anche in San Costanzo al Monte si ritrova l’orientamento tipico dell’architettura sacra cristiana, da Oriente verso Occidente. La zona absidale di epoca romanica costituisce, unitamente al tiburio ottagonale, la parte artisticamente più interessante di tutto il complesso. Osservandole dall’esterno, le tre absidi a base semicircolare sono scandite da una serie di lesene che termina nelle gallerie di coronamento superiore. Queste gallerie sono intervallate da diversi pilastrini, sulle cui sommità spiccano capitelli finemente scolpiti con svariate tipologie di forme, tra le quali il nodo di Salomone. Le absidi sono state costruite utilizzando dei blocchi squadrati in pietra, gneiss di color grigio-verde. Questa pietra costituisce l’ossatura del San Bernardo, il monte che sovrasta il Comune di Villar San Costanzo. Spiccano qua e là alcuni inserti in cotto che tendono a movimentare la cromia della parete esterna dell’edificio.
Le navate laterali sono coperte da volte a botte, la navata centrale è coperta da volte a crociera impostate su archi longitudinali e trasversali. La navatella meridionale venne tamponata in epoca napoleonica, quando l’edificio fu ceduto a privati che destinarono parte della chiesa ad azienda agricola. Anche all’interno della chiesa superiore è possibile seguire le diverse fasi dell’edificio nel corso dei secoli. La parte artisticamente più interessante è costituita dall’insieme delle strutture romaniche ascrivibile alla metà del XII secolo ossia le tre absidi, le ultime tre campate rivolte ad oriente ed il tiburio, mentre la costruzione aggiunta nella parte occidentale è stata datata al secolo XIII. In corrispondenza del tiburio, si nota la presenza sul piano pavimentale di un rosone realizzato attraverso l’utilizzo di diversi materiali: marmo, pietra naturale, mattonelle in cotto e giunti in calce.