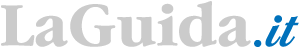Presentato in anteprima al 42° Torino Film Festival e in arrivo nelle sale a gennaio 2025, il documentario “Il mestiere di vivere” di Giovanna Gagliardo esplora la straordinaria modernità della figura di Cesare Pavese, amalgamando sapientemente nuove interviste e materiale d’archivio.
Il titolo è lo stesso del celebre “diario-zibaldone” dell’autore, e dietro le quinte c’è un meticoloso percorso di ricerca che ha richiesto quasi tre anni di lavoro. Un sentiero che, com’è ovvio, non poteva non includere anche la provincia Granda: non soltanto la regista condivide con Pavese la terra di origine (Giovanna Gagliardo è nata nel 1941 a Monticello d’Alba), nonché quello che lei stessa definisce “ lo spirito ostinato degli abitanti della Langa”, ma è lo stesso documentario a soffermarsi – nel suo primo atto – sulle radici albesi dell’autore, facendo dapprima visita al museo pavesiano di Santo Stefano Belbo, per poi mettere in scena il tradizionale ballo a palchetto della collina albese, raccontato con le parole di Anguilla ne “La luna e i falò”. Vietato però, attribuire a Pavese l’etichetta di “autore locale”.
Giovanna Gagliardo, come nasce questo equivoco?
Per dirla con il linguaggio dei ragazzi di oggi, Cesare Pavese è spesso considerato una figura “local”, e per questo poco affascinante: niente di più lontano dal vero. Bisognerebbe invece iniziare a considerarlo un autore “global”. Quando Pavese parla della “vigna”, o del suo “paese”, affronta concetti universali: chi ha familiarità con le Langhe ci può senz’altro rivedere la propria terra, ma il suo messaggio va al di là dello spazio e del tempo, ed è rivolto a tutti noi. Soprattutto alle nuove generazioni.
Perché ritiene che i giovani debbano riscoprire la figura di Cesare Pavese?
Penso che sia molto difficile, per i ragazzi della cosiddetta “Generazione Z”, trovare il proprio posto nella società di oggi. Il mondo è sempre più complesso, e non ci sono più ideologie o grandi movimenti con cui identificarsi. È fisiologico sentirsi soli e fuori posto, o avvertire un senso di disagio, soprattutto dopo la pandemia. Da parte sua, Pavese fa i conti con questi problemi con oltre 70 anni di anticipo. È fermamente antifascista, ma non riesce a innamorarsi delle ideologie politiche del dopoguerra. Lavora in Einaudi, ma va spesso controcorrente rispetto alle scelte della casa editrice. Vive in un’epoca di sogni e di promesse, ma non riesce a togliersi di dosso l’inquietudine, il disagio esistenziale e il senso di non appartenenza. Cosa c’è di più attuale?
I titoli di testa recitano “Da un’idea di Giovanna Gagliardo”. Qual è quest’idea che ha ispirato la realizzazione del documentario?
Quando si pensa a Cesare Pavese, si pensa quasi sempre a un individuo tormentato, che si è tolto la vita: in realtà, Pavese era molto più di questo. Fin da subito, la mia idea è stata quella di tracciarne un ritratto a tutto tondo, che non lasciasse fuori nulla: gli studi giovanili, gli anni della guerra, la letteratura, la politica, l’attività di traduzione, la passione per la cultura americana, l’amore per il cinema, le donne e tanto altro ancora. Di lì è nata l’idea di un documentario “narrativo”, con vari capitoli dedicati alle molte facce di quest’uomo così poliedrico. Ho scelto di partire subito dalla fine e da quel momento di cui tanto si parla, il suicidio del 1950, per “sbarazzarmene al più presto”, in pochi minuti. Di lì, mi sono guardata indietro e sono andata alla ricerca dell’uomo Pavese, in tutta la sua complessità.
Il documentario è a colori, ma sono presenti varie scene d’epoca in bianco e nero. Ogni volta, però, qualche elemento che viene restituito al suo colore naturale: una bandiera rossa, una bandiera tricolore, le luci gialle della città, i microfoni…
Com’è ovvio si tratta di animazioni digitali, realizzate in postproduzione. A volte volevamo evidenziare un dettaglio, o una curiosità storica: negli anni Cinquanta, ad esempio, i sacchi di juta delle Poste avevano delle caratteristiche strisce verdi, e ci tenevamo molto a evidenziare quell’elemento. In altri momenti, l’idea di fondo era quella di rendere colorato, attuale e immediato quello che troppo spesso può sembrarci un passato grigio e sbiadito. Il risultato è la prova che un approccio “artigianale” e ragionato alle nuove tecnologie può dare grandi risultati. Se ben indirizzati, il digitale e l’intelligenza artificiale offrono grandi possibilità ai narratori, a condizione però che non si perdano le redini e non si metta da parte la volontà di raccontare la propria storia.

Giovanna Gagliardo