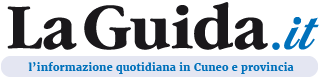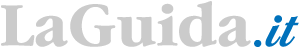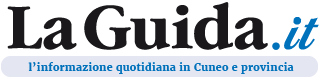Con l’inizio di agosto nelle campagne si incominciava a raccogliere i primi frutti, a partire dal frumento, che si valutavano dalle riserve sui fienili e dai pagliai nelle aie delle cascine. Così si poteva dare inizio a festeggiare, pur come breve momento di sosta, perché i raccolti successivi si intrecciavano con il peso dell’aratura dell’autunno.
In questi faticosi ritmi di lavoro, che coinvolgevano la maggior parte della popolazione dei nostri paesi, fin dal medioevo si era formato il calendario delle feste patronali. San Lorenzo, festeggiato il 10 agosto, ne era l’inizio. La scelta di tale data aveva anche radici astronomiche, con le stelle cadenti, e forse giuridiche: San Lorenzo, diacono a servizio dei poveri, segnava in varie zone la raccolta delle decime. San Michele, celebrato il 29 settembre, chiudeva un ciclo di sette domeniche, in cui i paesi di un circondario organizzavano le feste patronali.
La scelta della festività era ritmata da tradizioni secolari, in modo che due paesi vicini non la celebrassero la stessa domenica, per non creare ulteriori dissidi, in tempi in cui le guerre si facevano tra paesi a causa di diritti di pascolo, di acqua e di tanti altri pretesti, che spesso portavano alle botte anche nelle feste patronali. Infatti al di là di questo, le parentele si estendevano in zone più ampie dell’ombra dei campanili e la festa era occasione per riunire il parentado.
Il fatto che sei parrocchie nella diocesi di Cuneo-Fossano siano dedicate a San Lorenzo non è significativo che da quel paese iniziasse il ciclo festivo di una zona, poiché alcune di esse sono di fondazione recente e molti paesi ricorsero a santi secondari pur di fare festa nel periodo adatto. Solo nelle recenti generazioni non si guardano più nè santi è stagioni per fare festa.
Servizio completo su La Guida di giovedì 24 luglio 2025, disponibile in formato cartaceo e digitale