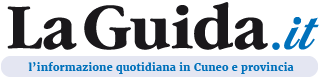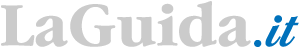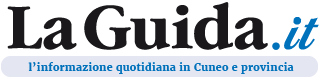(foto Pixabay)
Li chiamano “Leoni da tastiera”. Secondo Treccani.it questa espressione identifica “Chi, in Internet e in particolare nei siti di relazione sociale, si esprime in modo aggressivo e violento, non di rado ricorrendo a offese, insulti, minacce”. Su Wikipedia (che si autodefinisce “enciclopedia libera e collaborativa del web”) si legge che si tratta di “un’espressione dispregiativa e sarcastica del gergo di Internet usata per riferirsi a utenti del Web e dei social network che, quando esprimono i propri pensieri, utilizzando la rete si atteggiano in modo aggressivo, spesso insultando, offendendo, screditando o minacciando altri utenti, ma che non farebbero lo stesso di persona nelle relazioni umane.
L’espressione fa riferimento al fatto che tali comportamenti sono agevolati dalla sensazione di deresponsabilizzazione derivante dall’uso di utenze anonime”. Sebbene Treccani e Wikipedia (con tutto il rispetto per quest’ultima) non possano essere messe sullo stesso piano, il contesto social e web nel quale operano i “leoni” rende particolarmente interessante due specificità valorizzate dalla seconda; chi ha compilato la voce, infatti, ha sottolineato, da un lato, che gli insulti o le minacce non sarebbero stati pronunciati “di persona” e, dall’altro lato, che questi comportamenti sono agevolati dall’anonimato.
Effettivamente, la sensazione è che il web e il mondo social, in qualche modo, agevolino certe derive. Le cronache, anche locali, raccontano vicende che denotano una certa propensione a “dire” via social o web, ciò che, probabilmente, non sarebbe stato pronunciato di persona, guardando in faccia il malcapitato destinatario di ire, rancori o invidie. Quanto all’anonimato, dovrebbe essere oramai chiaro che, molto spesso, si tratta solo di una percezione senza fondamento, dato che, in gran parte dei casi, non è difficile risalire ai responsabili.
Difficile, senza cadere nel banale, spiegare perché capitino certe cose. Certamente, l’assenza fisica del destinatario contribuisce a eliminare o a limitare l’azione dei freni inibitori. Le dinamiche scatenate dai “branchi digitali” possono incidere, rendendo più semplice accodarsi agli improperi o alle minacce altrui. Tutto esatto, ma la vera domanda, da consegnare agli esperti, è perché le persone avvertano la necessità di impiegare il proprio tempo nel dire male di qualcuno o a qualcuno, magari sconosciuto, anziché fare una passeggiata, leggere un giornale, un libro, ascoltare della buona musica, oppure concedersi un sonno ristoratore.
Evidentemente, si toccano temi che riguardano le profondità dell’animo umano e, come detto, è facile banalizzare o semplificare. Quello che è certo, però, è che l’ordinamento giuridico, oramai da tempo, ha elaborato e applicato risposte ben precise per proteggere la dignità, la salute e la riservatezza di chi è digitalmente insultato e minacciato. Gli autori di questi gesti vengono, infatti, processati e, se i fatti sono accertati, condannati, in sede civile e penale, con conseguenze serie anche per chi non aveva percezione di fare qualcosa di male, o aveva una visione minimizzatrice o deresponsabilizzante sulla gravità di questi fatti. Ciò che si comunica nei social o nel web, infatti, ha la stessa rilevanza come se avvenisse nel mondo fisico. Lo hanno sperimentato, a loro spese, le 10 persone che, a Cuneo, hanno risarcito i danni al padre di quattro bambini per alcuni commenti su Facebook. Non si sa come andrà a finire il processo per altre 13 persone, accusate di diffamazione. Il rispetto della presunzione di innocenza impone cautela ma, certamente, non si tratta di una vicenda piacevole per nessuno.
Come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, del resto e in linea generale, quando si trasmettono contenuti oggettivamente offensivi, non conta neppure la natura privata dell’applicativo di messaggistica, se c’è anche solo la consapevolezza che ai contenuti offensivi possano avere accesso più persone.
Il web e i social non sono mondi a sé, dove le regole che disciplinano la vita civile non hanno cittadinanza. Non esiste alcuna “immunità digitale”. Al contrario, proprio perché questi canali possono amplificare la portata offensiva o minatoria di certe parole, oppure generare spirali di accanimento verso persone che hanno ben pochi strumenti per difendersi, le conseguenze possono essere più serie di quanto sarebbero nel mondo fisico.