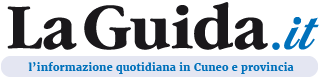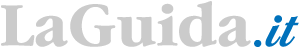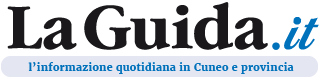Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20
La raccolta di istruzioni ‘pastorali’ che il vangelo ci offre può far nascere suggestioni interessanti per il cattolicesimo messo nuovamente per strada da questo tempo secolarizzato.
Fino a non pochi decenni fa, per le nostre comunità credenti più che annunciare il vangelo sembrava sufficiente gestire una religione dove il tono che prevaleva non sempre e primariamente era quello della buona novella.
Certamente, annunciando il Regno, Gesù richiede la conversione. Ma a renderla possibile è una grazia che viene prima, che precede, detta da Isaia come «consolazione» e da Paolo come «novità» dove il Signore stringe una nuova e perenne alleanza con l’umanità.
Forse un po’ costretti dai tempi, anche noi abbiamo imparato a concentrare nuovamente la sostanza dell’annuncio evangelico anzitutto nella misericordia che Dio riserva al mondo. Non si tratta di una benevolenza a buon mercato ma della convinzione che il Dio di Gesù Cristo è sempre a fianco degli uomini nel teatro del mondo, sul terreno della storia, nel cuore della vita, combattendo per e con l’uomo il male che ne minaccia l’esistenza.
Non per nulla il gesto che annuncia la presenza attiva del Regno di Dio è infatti la cura che fronteggia il male: «Guarite i malati che vi si trovano».
Per altro, il discepolo non riceve molte indicazione sul ‘contenuto’ se non lezioni di sobrietà e di misura.
La prima lezione è un invito ad avere un atteggiamento di gratuità.
Il discepolo, il testimone non è un imbonitore interessato ad imporre i suoi prodotti con sforzi pubblicitari raffinati e costosi. Quindi non accumuli troppi ‘beni’ col pretesto dell’efficacia. La capacità di persuadere di un annuncio, sta anche nella leggerezza che lo accompagna. La causa del vangelo non di rado è stato screditato da un mondano faccendismo, da un’astuzia volta ad ottenere quel gradimento umano che pure il vangelo può suscitare in mezzo agli uomini, così come quando la missione è stata confusa con l’occupazione dello spazio sociale.
Una seconda lezione sta nella libertà interiore del testimone da quella ossessione del gradimento e da quella fissazione per l’audience che finisce col personalizzare, incentrare su di sé, il senso della missione evangelizzatrice.
Dal successo o dal rifiuto, il testimone può correre il rischio di misurare sé stesso accumulando, a seconda dei casi, montagne di narcisismo o abissi di depressione. In entrambi i casi non ha nemmeno occhi per i miracoli che si producono nel mondo e per i quali dovrebbe potersi rallegrare.
Ai discepoli, infatti, che ritornano gioiosi perché la loro missione è stata straordinaria, il Maestro insegna loro che un altro deve essere il motivo della gioia: «Non rallegratevi perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».