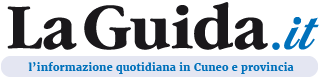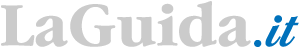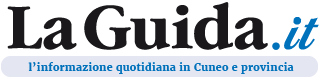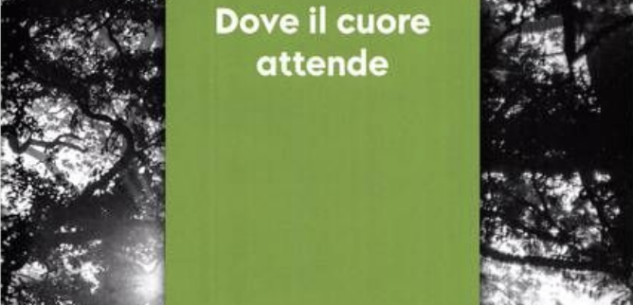“La speranza si manifesta quando appare in tutta la sua forza implacabile l’impotenza radicale dell’uomo a respingere i limiti dell’esistenza”. Frédéric Boyer ribadisce così in forma sintetica e assertiva la descrizione della sua personale esperienza con cui aveva aperto il libro. Giorni drammatici che lo avevano condotto sull’orlo del suicidio, consegnandolo a un’”anarchia” letta in senso letterale come assenza di un nuovo inizio.
I libri di Boyer si precisano infatti come diari intimi. L’autore apre il proprio animo. Condivide l’esperienza del frugare nel proprio cuore, che non è mai uno scorticarlo, bensì denudarlo delle apparenze fallaci per coglierne la fragilità. Il testo sulla speranza si struttura saldamente su questa metodologia di analisi ponendo come prima asprezza da affrontare il tema della traduzione.
Il libro si apre dunque sul paesaggio interiore devastato, inerte, chiuso nel circolo vizioso della depressione. Esattamente l’opposto di ciò che il titolo promette. Eppure è proprio in questo stridente contrasto che sta il nucleo delle pagine. Il terreno dove germoglia la speranza è quello in cui “la vita non può più essere interpretata”, allorché ci si scopre “cavalieri nudi”.
Una discesa agli inferi che Boyer arditamente definisce “messianica” in quanto foriera di un’attesa insaziabile di senso. Lì l’autore incontra Noè, personaggio simbolo di un “re-inizio”, di una nuova creazione, di un’apertura di credito all’impossibile. È la speranza “folle, idiota, stravagante”, perché “apre una possibilità, ma allo stesso tempo riconosce di non sapere nulla della sua realizzazione”.
Boyer non cade nel tranello di cercare un “contenuto” per la speranza. È piuttosto un atteggiamento intimo. Rimanda alla visione in quanto guarda oltre. Non nel tempo, bensì nella profondità. Non è una caparra sull’evento sperato, bensì un “pegno per un supplemento di dignità”, perché sprona la vita, rimette sulla strada tenendosi lontana dalle accuse di fuga dal reale, di debolezza.
Ciò consente di ancorare la speranza al presente, anzi di farne un rimedio all’appiattimento dell’oggi: “vivere senza il desiderio di trasformare”. Chiama in causa l’economia e la politica nella misura in cui mette in discussione il possesso, perché “ciò che spero non lo possiedo”. Faust è la figura della speranza affaticata del contemporaneo, incarnazione dell’immediato.
L’autore, pur professandosi credente, lascia che gli appelli alla fede rimangano spunti disseminati in abbondanza, quasi inviti a leggere “oltre”, anche laddove si confronta necessariamente con Giobbe o col pensiero di Paolo. Il terreno su cui la speranza può confrontarsi con l’Assoluto rimane drammaticamente umano.
Speranza. Dove il cuore attende
di Frédéric Boyer
Editrice Sanpino
euro 16