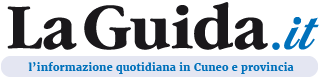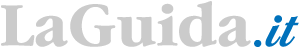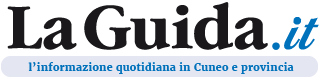Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
Le Beatitudini, poste da Matteo all’inizio del «Discorso della montagna» (Mt 5,1-12), in Luca hanno un’altra ambientazione. Dopo una notte di preghiera sul monte, Gesù scelse i Dodici e assieme a loro discese verso un luogo pianeggiante; là iniziò il suo discorso.
Nel vangelo secondo Matteo prima delle beatitudini Gesù non si era ancora scontrato con il muro del rifiuto. Forse per questo in Matteo non ci sono i «guai», mentre Luca non è nelle condizioni di prescindere da un linguaggio duale (presente anche in Geremia 17 e nel Salmo 1).
«Discorso della pianura» in Luca che non è piano: «guai», appunto, non nascondendo, anzi alludendo apertamente al linguaggio della persecuzione, dell’odio, del disprezzo. Il «voi» rivolto ai discepoli rivela il legame con il Maestro che nel corso della sua missione aveva già iniziato a sperimentare la povertà, la fame, il pianto e la persecuzione.
Tra i motivi che hanno indotto Luca a collocare il discorso delle beatitudini in un luogo piano, probabilmente c’è una componente di umiltà che si trasforma in esempio. Nella premessa al discorso si trova una notazione insolita: «Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva…».
In tutte le iconografie ispirate al «discorso della montagna» Gesù si trova nella posizione più elevata. In questo caso i suoi occhi devono piuttosto abbassarsi.
Luca invece pone Gesù in una condizione umile, quasi che i suoi discepoli stessero più in alto di lui.
In questo particolare è racchiuso un invito a tutti i discepoli di ieri e di oggi a collocarsi più in basso di quello che si è. Se non si è in proprio poveri, occorre stare dalla loro parte; se in prima persona non si ha fame, non bisogna dimenticarsi di chi ce l’ha; se non si piange, è necessario condividere il pianto altrui; se non si è perseguitati, si deve essere consapevoli che molti lo sono.
Le beatitudini contengono un annuncio paradossale che rovescia il comune sentire: sono proclamate felici persone che si trovano in condizioni di sofferenza. Può pronunciare simili parole solo chi ha attraversato quelle fatiche e in esse vi ha scorto una luce possibile che consente di affrontarle con coraggio. Gesù ha provato la fame, ha conosciuto la persecuzione e attraverso di lui possiamo entrare anche noi nello spirito di questo messaggio.
Per coloro che piangono e sono afflitti Gesù non proclama la fine della sofferenza, né delle molte cause che la provocano, ma afferma la speranza di un mondo nuovo che rende possibile vivere il presente in una prospettiva diversa. La possibilità di un cambiamento già qui e ora per i tanti afflitti della terra è affidata a ciascuno di noi, nella misura in cui teniamo gli occhi ben desti per vedere e riconoscere le numerose situazioni di disagio attorno a noi; tendiamo una mano a chi si trova in condizione di bisogno; custodiamo un cuore sensibile, capace di compatire perché non indurito dall’indifferenza e dalla ricerca del proprio tornaconto.
Sempre, per la Bibbia, si deve scegliere tra la via della vita e la via della morte. Per cui le beatitudini cui Gesù si rivolge sono motivate anche dal confronto con la situazione opposta.
Per Gesù è beatitudine la povertà del povero a confronto con la ricchezza del ricco che crea i poveri e li umilia e li affanna.
Gesù chiama beatitudine la pace della coscienza di chi non fa del male agli altri. Per chi abita il proprio cuore, meglio essere afflitti che affliggere. Meglio patire la povertà che causarla ad altri.
E Gesù visse lui stesso queste beatitudini, lui che sempre preferì diventare un escluso piuttosto che escludere o tollerare che altri restassero esclusi.
Ogni condizione di beatitudine ci appare in tutto il suo significato quando è la sola alternativa, nella realtà, al produrre noi quell’ingiustizia. Povertà, afflizione, ingiustizia, persecuzione: in questo mondo ingiusto molto spesso l’unica alternativa ad essere artefici di questi dolori è essere tra quelli che li subiscono, come Gesù.
La consapevolezza di questo rende beati.
Qui sta l’insegnamento evangelico: che fare il male fa male anche a chi lo fa, e non solo agli altri che lo subiscono; che rifiutarsi di fare il male dà una gioia profonda. Beatitudine è avere il pensiero e lo Spirito di Gesù, è la pace che visse Gesù, che preferì sempre sopportare l’ingiustizia piuttosto che infliggerla.