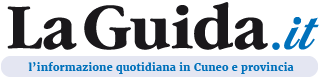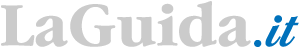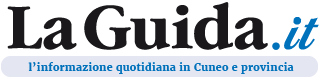Photographer: Mauro Bottaro, European Union, 2017, Copyright, Source: EC – Audiovisual Service
Chi protegge i nostri dati personali? Quali sono i sistemi di posizionamento usati in Europa? Queste le tematiche principali affrontate in occasione del quarto appuntamento con “Le parole per capire l’Europa”, format organizzato dai centri Europe Direct di Cuneo, Torino e Vercelli, che prevede sei incontri volti ad approfondire il panorama europeo attuale partendo dalla riflessione su alcune parole chiave. Gli incontri online, della durata di un’ora, sono destinati ai ragazzi delle scuole superiori.
Il terzo incontro, svoltosi il 17 dicembre 2024, ha trattato il tema dell’alimentazione in Europa, con un’attenzione particolare alla sostenibilità in agricoltura e ai problemi che la produzione di cibo comporta al pianeta e ai suoi abitanti.
Durante il quarto incontro dedicato al tema della geolocalizzazione e della protezione dei dati personali, tenutosi il 22 gennaio 2025, sono intervenuti Giancarlo Granero, capo unità presso la Direzione generale per l’Industria della difesa e lo spazio della Commissione europea, e Ludovica Paseri, assegnista di ricerca in Filosofia del diritto e Informatica giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
Che cosa si sta facendo in Europa riguardo i sistemi di posizionamento? Nel panorama globale dello spazio e dell’industria della difesa, un ruolo di primo piano è svolto dal sistema di geolocalizzazione Galileo, fiore all’occhiello dell’Unione Europea, progettato per inviare segnali radio per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo. Ideato a partire dal 2001, Galileo è entrato ufficialmente in servizio nel dicembre 2016 e attualmente rappresenta il miglior sistema al mondo per il PNT (Positioning, Navigation and Timing).
Viviamo in un’epoca in cui la dipendenza dall’uso dei satelliti è diventata quasi totale: dalle applicazioni sui nostri smartphone alla gestione delle infrastrutture critiche. Galileo si distingue per la sua alta precisione, la disponibilità del segnale e l’affidabilità, caratteristiche di fondamentale importanza per uno strumento di questo tipo. Il sistema garantisce una copertura continua, immune da interferenze (da cose e persone) e con un sofisticato meccanismo di autenticazione che verifica l’integrità del segnale, prevenendo modifiche da attori esterni.
A livello globale, esistono quattro principali sistemi di geolocalizzazione satellitare o GNSS (Global Navigation Satellite System):
- GPS (americano): sistema militare open source;
- GLONASS (russo): considerato il meno accurato;
- BeiDou (cinese);
- Galileo (europeo): unico concepito per un uso civile, sebbene interagisca anche con il GPS.
Con 32 satelliti operativi, di cui 27 attivi e 5 con funzione di riserva, Galileo ha effettuato lanci significativi nelsettembre 2024 grazie ai razzi SpaceX di Elon Musk, mentre il prossimo passo sarà l’utilizzo del vettore europeo Ariane 6, il cui secondo lancio è programmato per la fine di febbraio 2025. La postazione di lancio europea principale si trova nella Guyana Francese, mentre le operazioni a terra sono supportate da un’ampia rete di stazioni disseminate in tutto il mondo. Ogni satellite, delle dimensioni di un’automobile, è equipaggiato con quattro orologi atomici per garantire una precisione senza precedenti.
Un elemento distintivo è il sistema di ricerca e salvataggio (Search and Rescue – SaR) integrato in Galileo, che si basa sul COSPAS-SARSAT, il sistema satellitare internazionale progettato per assistere le operazioni di ricerca e soccorso. Al tempo stesso, il progetto dell’UE IRIS² (acronimo di Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) rappresenta un ulteriore passo verso la connettività satellitare europea.
L’uso di Galileo, dunque, non si limita agli smartphone, ma si estende a molteplici ambiti, dall’industria all’agricoltura, rendendo evidente il legame tra tecnologia satellitare e vita quotidiana. L’industria aerospaziale, con realtà d’eccellenza come il polo aerospaziale di Torino, ci mostra come la tecnologia sia un potente alleato per l’innovazione e lo sviluppo. Tuttavia, se da un lato è innegabile il grande potenziale di questi strumenti che riescono costantemente a reperire informazioni dai nostri spostamenti e dalle nostre azioni, dall’altro è lecito chiedersi chi si occupa di proteggere i nostri dati personali.
La nostra relazione con la tecnologia, in particolare con gli smartphone, solleva senza dubbio questioni etiche e culturali. La professoressa Paseri sottolinea come i dispositivi mobili siano ormai un’estensione della nostra persona. Questa dipendenza dallo smartphone, analizzata anche da autori come August Lamm (“You don’t need a smartphone: a practical, personal guide to downgrading your device”) e Juan Carlos de Martin (“Contro lo smartphone. Per una tecnologia più democratica”), ci invita a riflettere sull’uso spesso eccessivo o sconsiderato di questi strumenti e sulle implicazioni per la nostra identità personale. Inoltre, questi dispositivi hanno un impatto non indifferente anche sull’ambiente: pensiamo alle materie prime necessarie per costruirli ma anche alle problematiche legate al loro smaltimento.
In relazione all’impatto sulla sfera dei diritti, il giurista Stefano Rodotà ha introdotto il concetto di habeas data, un’estensione del principio medievale dell’habeas corpus. Se quest’ultimo tutelava l’inviolabilità del corpo fisico, l’habeas data difende oggi il “corpo elettronico” composto dai nostri dati personali, custoditi in gran parte proprio negli smartphone. Si tratta di un tema centrale nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nella quale proprio gli articoli 7 e 8 sanciscono il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, ma rappresenta altresì il fulcro del GDPR(Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Considerati i numerosi rischi a cui sono esposte le nostre identità, sarà necessario un ritorno al passato? Sebbene lo smartphone possa essere considerato l’oggetto simbolo della nostra era, alcune persone, come August Lamm, propongono un ritorno al cosiddetto “dumbphone”, ossia il vecchio telefonino degli anni novanta che permetteva solo chiamate e messaggi. Si tratterebbe di una scelta che invita a ripensare il ruolo della tecnologia nelle nostre vite, riducendo la dipendenza digitale e riscoprendo una dimensione più autentica dell’esistenza.