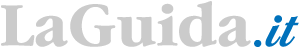“Erano i ragazzi che ci chiedevano continuamente di poter lavorare perché avevano bisogno di soldi e per dare senso alle loro giornate, noi li abbiamo messi in contatto con aziende che cercavano lavoratori”. Con queste parole M. M., responsabile della struttura di Racconigi che dal 2016 ospitava circa 50 migranti, ha spiegato il ruolo che aveva cercato di svolgere a favore dei giovani migranti presi in carico dalla cooperativa di cui era dipendente, rigettando le accuse che lo vedono imputato di sfruttamento del lavoro per essersi intascato i 5 euro che i ragazzi pagavano per essere portati sul posto di lavoro con il pulmino della cooperativa e per averli costretti a lavorare per le aziende da lui indicate pena l’estromissione dal centro. Dalle carte dell’indagine risultò che uno dei datori di lavoro pagava i suoi dipendenti con compensi in busta paga inferiori al numero di ore effettivamente lavorate, fornendo il resto in nero. L’uomo patteggiò subito la pena e uscì al processo.
Per quanto riguarda invece le accuse mosse contro l’ex direttore della struttura di Racconigi, nelle precedenti udienze erano stati gli stessi ospiti a riferire che M. M. non era affatto coinvolto con il pagamento dei 5 euro per il trasporto da e per il luogo di lavoro, che a partire dal 2018 era stato organizzato dall’azienda agricola per cui lavoravano i ragazzi, prelevando dalle loro buste paga il corrispettivo di 5 euro al giorno. Il problema del trasporto si era posto però già un anno prima perché gli spostamenti dei giovani in bicicletta non erano sicuri – un giovane iraniano era morto in un incidente stradale – e la cooperativa, dopo aver ricevuto una serie di preventivi piuttosto salati da aziende di trasporto locali, aveva deciso di usare il pulmino della cooperativa chiedendo un rimborso spese di 5 euro a ogni ragazzo. I soldi finivano in una cassa comune per ripagare le spese di benzina e manutenzione e per spese extra: “La scelta di usare il pulmino era stata presa da tutti insieme, cooperativa e ragazzi. I soldi venivano usati per i bisogni in più, il gelato d’estate, i datteri, qualche sfizio per i ragazzi”, ha spiegato M. M. al giudice. I soldi finiti in quella cassa comune non erano però rendicontati e la cooperativa decise di sospendere quel servizio di cui, l’anno dopo, si occupò direttamente il datore di lavoro dell’azienda per cui lavoravano i migranti.
Per quanto riguarda l’accusa di aver costretto i giovani a lavorare per le aziende da lui indicate, l’uomo ha spiegato che quei ragazzi erano tutti richiedenti asilo: “In quanto tali non avevano bisogno di dimostrare che lavoravano per avere il rinnovo del permesso di soggiorno. I richiedenti asilo sono persone che scappano perché perseguitate nei propri Paesi di origine. Una volta accertato lo status il rinnovo era automatico”, ha spiegato l’uomo. Infatti alcuni ragazzi non lavoravano affatto, preferendo studiare l’italiano e magari conseguire il diploma di scuola media per avere in futuro migliori occasioni di lavoro. In aula ha infatti parlato l’insegnante che teneva questi corsi e una volontaria impegnata a incrementare le ore di lezione per accelerare il percorso di apprendimento. Insieme a un’altra volontaria hanno riferito delle tante iniziative volte a migliorare l’integrazione fra gli ospiti della struttura e la cittadinanza inizialmente restìa ad accettare la presenza del Cas nel centro cittadino: “Con il Comune erano stati individuati dei servizi di pubblica utilità che loro ritengano molto importanti perché gli dava un ruolo. Dicevano ‘io lavoro per il Comune’, era una cosa importante per loro”. L’udienza è stata rinviata al 24 ottobre per i residui testimoni della difesa.