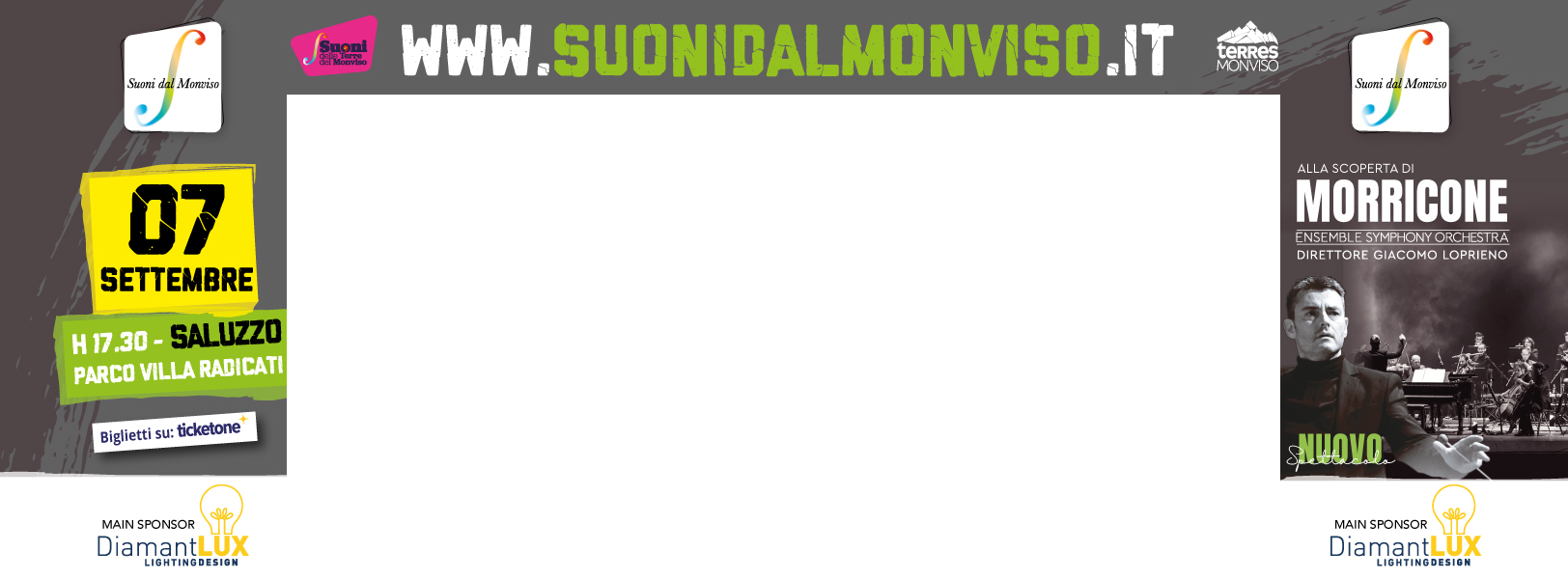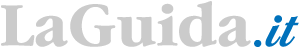Torino – Credevate che il capitalismo globalizzato fosse una conseguenza della rivoluzione industriale e dei suoi sviluppi? Che il prototipo della produzione di massa avesse a che fare con la teorizzazione di Taylor prima e la sua applicazione da parte di Ford a Detroit dopo? Errore. Il nucleo da cui prenderebbe avvio l’onnipervasività dell’economia di mercato e del consumismo sono le piantagioni di banane create in Costa Rica negli anni Settanta del XIX secolo: autore di questo gesto rivoluzionario sarebbe l’americano Minor Cooper Keith, co-creatore de facto della prima vera multinazionale (la United Fruit Company, nota ora come Chiquita), capace di sviluppare in men che non si dica un nuovo bisogno globale, un impero economico e una rete di inquietanti manovre politiche all’origine di colpi di stato (e non solo) in America Latina. Ovvero nelle cosiddette, appunto, “repubbliche delle banane”.
E’ questa la tesi proposta da “Kingdom”, uno spettacolo tanto divertente e visionario, quanto intelligente e provocatorio presentato dai celeberrimi Agrupación Señor Serrano: un gruppo di cui qui si è parlato spesso, fin dalla loro apparizione all’edizione 2015 del festival “Mirabilia” a Fossano, negli stessi giorni in cui il gruppo spagnolo riceveva il Leone d’Argento alla Biennale Teatro di Venezia. Andato in scena alla 24° edizione del Festival delle Colline Torinesi(Teatro Astra, Torino, 13-14 giugno), questo nuovo lavoro nasce dallo shock della crisi economica del 2008 e dalla convinzione da parte di Àlex Serranoe soci che, nonostante tutto, nulla in seguito sia di fatto cambiato. I meccanismi del capitalismo ancora una volta, a parer loro, sono rimasti in piedi, all’insegna di un ottimismo sistemico che riesce a inglobare tutto: “estamos bien” è la frase che fa da mantra allo spettacolo. Per un gruppo per cui probabilmente il teatro non è che la continuazione della politica con altri mezzi, la banana diventa il fulcro di un racconto realistico e fantastico dove il gusto per la narrazione e la provocazione s’avvicenda a dati storici e scientifici, come il fatto che questo frutto sia il più venduto al mondo e che ciascuno di essi non sia che un clone del tipo Cavendish, impostosi dopo che la cosiddetta “epidemia di Panama” colpì le piantagioni di tutto il mondo nella prima metà del ‘900. A simboleggiare il capitalismo sfrenato e il suo carattere maschilista entra ad un certo punto il personaggio di King Kong, elaborato da Hollywood in piena Grande Depressione e oggetto successivamente di riedizioni, quasi a punteggiare l’alternarsi di momenti di crescita a apparenti crisi sistemiche che caratterizzano l’economia mondiale.
Il narratore (Pablo Rosal) propone questa specie di controstoria del capitalismo mentre sul palcoscenico il gruppo mescola come al solito, genialmente, teatro, cinema e arti visive. Oggetti, pupazzetti, miniature, immagini di ogni genere, pubblicità della Chiquita e foto di Carmen Miranda con banane in testa, copertine di giornali (vere o inventate), filmati d’epoca, video da YouTube e chi più ne ha più ne metta vengono ripresi (da soli o con gli attori) con una telecamera, costruendo in diretta sullo schermo che sovrasta la scena una sorta di film o programma televisivo. Ma non manca la musica dal vivo affidata al musicista catalano Nico Roig(vestito, ovviamente, da banana) e al rapper/attore cinese Wang Ping-Hsiang, autore di interventi canori decisamente spassosi. In un crescendo di ritmo, di suoni e di immagini di ogni tipo, Agrupación Señor Serrano propone amaramente di sostituire la rivoluzione chiaramente impossibile con una festa senza limiti. D’altronde “estamos bien”, no? Ecco così che, nello spettacolare finale all’insegna della techno, appaiono alcuni giovanotti piuttosto muscolosi (scovati nelle palestre torinesi) i quali, accanto ai cinque attori/performer restati ormai letteralmente in mutande, si abbandonano ad una haka māori dal machismo decisamente improbabile, concludendo così – a tutto volume – una messinscena davvero notevole.
Tra i 24 spettacoli dell’edizione 2018 del Festival, ideato e realizzato con la sua consueta intelligente effervescenza da Sergio Ariottie Isabella Lagattolla, merita attenzione per il carattere innovativo del linguaggio drammaturgico anche “La plaza”, proposto da un altro gruppo spagnolo, El Conde de Torrefiel(ancora all’Astra, 20-21 giugno). Un lavoro – anche questo molto politico – che, come hanno spiegato in un’intervista i due registi, Pablo Gisbert e Tanya Beyeler, nasce da una semplice domanda: “Come è possibile che tutte le democrazie in Europa stiano svoltando politicamente a destra se i miei mille amici di Facebook sono tutti di sinistra?”. Troppo spesso un po’ tutti – e quindi anche gli spettatori del teatro di ricerca – finiamo per vivere in piccoli mondi insieme a persone che, complici i social network, condividono le nostre stesse idee. Finché, di fronte al confronto con la realtà (la “piazza” reale), dove si parla in un modo che appare inaccettabile ad un pubblico per così dire colto, questi microcosmi finiscono per esploderci in faccia.
Un po’ teatro, un po’ installazione, un po’ riflessione filosofica, un po’ dibattito politico, “La plaza” cerca quindi di sollevare lo sguardo per trattare temi concreti con tutte le contraddizioni che ciò comporta. Propone cinque differenti “tableaux vivants”, di cui il primo (una distesa di fiori come una sorta di altare commemorativo) senza attori, i quali però, pur apparendo negli altri quattro (una piazza dove prevalgono donne velate, uno stupro, un gruppo di turisti in un museo, la ripresa di un film che ha come fulcro il cadavere nudo di una donna), non parlano comunque mai e agiscono nella scena con il volto reso anonimo da una tela color carne. La colonna sonora, particolarmente bella, alterna musica e suoni elettronici, dub, il post-rock dei canadesi Godspeed You! Black Emperor, ma anche l’ibrido tra post-punk, digitale vintage e krautrock dell’italo-londinese Alessio Natalizia in arte Not Waving.
A fare da collante de “La plaza” è però il testo, tutto in seconda persona singolare, proiettato sul fondo della scena e solo in parte collegato con quello che vede lo spettatore, invitato a immedesimarsi in questo “tu” che vive in una sorta di monade privilegiata, spesso con gli auricolari addosso, senza accorgersi quasi di ciò che lo circonda. Un tu che non ha un vero contatto con la realtà: assiste alla conclusione di uno spettacolo impossibile, durato per un anno in 365 città del mondo; legge i commenti su Twitter sulla fine di questo epocale e assurdo evento teatrale; riflette sul futuro, sul ruolo dei musulmani, sulle multinazionali, sulla possibilità di far parlare gli animali grazie alla tecnologia; cita libri colti e di moda (“2666” di Roberto Bolaño), quadri (Caravaggio), musicisti (Wagner, Schubert, Kanye West, Bob Marley); si lamenta del carattere ormai datato del post-rock, decide di non partecipare ad una festa; pensa alle opinioni di una sua amica sulla vitalità di Vienna; utilizza pornografia girata da un’attrice ormai morta da anni; si compiace che il sonno separi i giorni altrimenti tristemente sempre uguali. Come nell’esistenza inautentica descritta da Heidegger, dice, pensa e fa quello che si dice, si pensa e si fa nel piccolo mondo omologato dei suoi “mille amici delle reti sociali”, in una sorta di vuoto di cui non si capisce l’origine e la causa. Solo la morte, possibilità ineludibile, ci può costringere a prendere in mano il nostro vivere frammentato e disperso. In quella piazza che si è popolata di abitanti eterogenei per tutto il corso di questo straordinario spettacolo, solo la donna morta appare con il proprio volto.